|
|
|
1. PREMESSALa Comunità la Crisalide nasce nell’ottobre del 1998 per accogliere bambini vittime di maltrattamento e/o abuso sessuale. Ente gestore della comunità è l’Associazione di Volontariato “Margherita”.
2. FINALITÀ DELLA COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA “ LA CRISALIDE” Il maltrattamento e l'abuso sessuale compromettono le normali tappe dello sviluppo e della formazione del bambino. Un’esperienza di maltrattamento e/o d’abuso sessuale agisce sulla regolazione affettiva, lo sviluppo dell'autostima e si ripercuote sulle relazioni. I disturbi di relazione persistono nell'età adulta. I meccanismi patologici d’adattamento si manifestano in molteplici modi. La ricaduta di tali esperienze si manifesta attraverso disturbi cognitivi, fisici, comportamentali/emotivi. L’abuso impedisce al bambino di sviluppare le proprie potenzialità evolutive. Il disagio che deriva da un abuso si configura quindi come una condizione di difficoltà e sofferenza che impedisce il normale sviluppo psicologico dell’individuo.
STRUTTURAE’ sita in Napoli alla Via Aquila 144 (nei pressi della Stazione Centrale), primo piano. E’ di circa 140 mq. E’ provvista di 4 finestre e 2 balconi; 3 ampie camere; un grande salone; una cucina abitabile; una sala d’ingresso; un corridoio; due bagni di cui uno molto ampio. Lo stabile è provvisto di ascensore accessibile ai disabili.
6 minori compresi tra i 0 ed i 12 anni maltrattati ed abusati. Solo in casi eccezionali è previsto l’inserimento di un 7° ospite (vedi regolamento regionale)
MODALITÀ DI INVIOL’accoglienza di un qualsiasi utente avviene previo decreto del Tribunale per i Minorenni, o su Decreto del Comune competente (ex legge 403) confermato poi dal Tribunale per i Minorenni.
MODALITA’ DI PAGAMENTOL’ente gestore è disponibile a stabilire convenzioni con i Comuni interessati. Senza alcun accordo tra il comune inviante e l’ente gestore, il costo della retta giornaliera e di €123,00 dal 01.01.2011. I pagamenti saranno richiesti secondo le indicazioni del comune di residenza del minore ospitato.
LINEE GUIDANell’esercizio delle funzioni e conseguentemente, nella propria impostazione operativa e metodologica, la Comunità La Crisalide, ha recepito e fatto proprie le indicazioni del C.I.S.MA.I. riguardanti i requisiti dei centri residenziali per minori abusati e maltrattati. Tali requisiti sono definiti nel documento elaborato dalla Commissione Scientifica del coordinamento che si è occupata dell’accoglienza dei bambini vittime di maltrattamento, documento approvato dall’assemblea nazionale del CISMAI a Cosenza il 28 settembre 2001. La tipologia dell’utenza (minori in situazioni di crisi e le cui condizioni psicofisiche sono fortemente compromesse dai traumi subiti) e la complessità del contesto (familiare, sociale, clinico, giudiziario) in cui l’intervento della comunità si viene a collocare, determina la necessità di attivare nei confronti delle persone accolte specifiche azioni a valenza protettiva e terapeutica. Lo svolgimento delle essenziali funzioni educative, necessarie alla crescita dei bambini, ha quindi una connotazione e una valenza terapeutica, configurandosi come contributo specifico dell’equipe educativa all’equipe assistenziale integrata psicosociale. Le comunità per effettuare un intervento qualificato nei confronti dei bambini accolti devono rispondere ai seguenti requisiti: - Garantire una forte integrazione interprofessionale tra i differenti operatori coinvolti; - Possedere un’elevata specializzazione rispetto ai problemi affrontati; - Possedere un'adeguata capacità di rapportarsi con il percorso giudiziario in cui il minore e la sua famiglia sono coinvolti. Nel sistema organizzativo di cui si è dotata la comunità è rintracciabile a tutti i livelli ( funzionale, operativo, metodologico) il recepimento delle istanze espresse dal documento del CISMAI.
A titolo esemplificativo indicheremo qui alcune scelte operative che vanno in tale direzione. Operatore di riferimento La scelta dell’operatore di riferimento è tesa a garantire l’integrazione. In primo luogo l’operatore di riferimento è colui che segue più da vicino il bambino. Ne è il portavoce, ne custodisce la memoria individuale. Per questa sua prioritaria funzione, questi è individuato preferibilmente in base alle preferenze espresse dal bambino. L’O.d.R. inoltre è colui che registra ed assembla le informazioni provenienti dall’ equipe educativa. L’O.d.R. infine, in virtù delle funzioni precedentemente espresse, costituisce l’interfaccia tra la comunità ( comunità= bambino+ equipe) e l’equipe allargata. La formazione degli operatori Gli operatori sono tenuti a partecipare ad almeno un’iniziativa formativa ogni anno su tematiche connesse al lavoro svolto. Protezione delle visite Nei casi disposti dal giudice ( o anche a discrezione della Comunità ), si effettua un monitoraggio dei contatti e delle visite tra genitori e bambino. Gli operatori redigono una relazione sulla visita effettuata. Lavoro di preparazione e di sostegno del contesto sociale: scuola, tempo libero, sport. E’ evidente che tali bambini esprimono il loro disagio in ogni situazione che li riguardi. Per quanto riguarda la scuola la comunità, dispone per l’ottimizzazione del percorso educativo del bambino di un referente scolastico. Il referente scolastico costituisce l’interfaccia tra la comunità ( comunità= bambino+ equipe ) e la scuola. Questi, attraverso un uso corretto delle informazioni circa le problematiche del bambino, rende operativa la possibilità di raccordare l’intervento educativo svolto dalla comunità, con quello effettuato dalla scuola in un’ottica di responsabilità condivisa, e secondo uno stile di intervento collaborativo. Per quanto attiene lo sport, sono gli operatori a garantire l’inserimento attraverso misure d’accompagnamento varie.
ATTIVITÀLe attività offerte ai bambini sono rispondenti alle funzioni e gli obiettivi del progetto. Proteggere ed accogliere, in situazione d’emergenza e non, minori allontanati temporaneamente dalla famiglia poiché vittime di violenza fisica e psicologica, d’abuso sessuale e grave trascuratezza, tuttavia apre la strada alla necessità di informare tutto l’impianto organizzativo sulle specifiche caratteristiche di questo particolare tipo d’utenza. In base a queste considerazioni la Comunità si rende disponibile, ove si ritenesse opportuno per garantire gli obiettivi già esplicitati, ad ospitare anche il genitore protettivo. Funzioni, strumenti e organizzazione sono stati quindi opportunamente strutturati in relazione alla tipologia dell’utenza. Particolare attenzione, al fine di garantire l’efficacia dell’intervento, è stata data alla definizione progettuale dei percorsi educativi individualizzati durante la permanenza del minore in comunità a causa della complessità del contesto (familiare, sociale, clinico, giudiziario) in cui l’intervento si viene a collocare. La qualità del livello di cura e protezione garantita a questi bambini costituisce, infatti, elemento pregiudiziale rispetto agli sviluppi futuri della vita minore. A seguito di queste considerazioni, si terrà sempre presente nella progettazione interistituzionale l’esistenza o la creazione di un’alternativa al ricovero in comunità. Sarebbe, infatti, auspicabile che la durata del progetto d’inserimento nella comunità fosse contenuta a tempi brevi, giacché è evidente la necessità per il minore di godere del suo diritto a vivere in famiglia. Si sottolinea tuttavia la capacità e la volontà della comunità: > di accompagnare e proteggere il minore lungo tutto l’iter psicodiagnostico; > fornire collaborazione e supporto per eventuali valutazioni delle possibilità di recupero dei genitori o di altri familiari; > garantire percorsi d’inserimento tutelati per rientri nella famiglia di origine ; > di garantire percorsi di accompagnamento in caso di adozione/affidamento del minore. > di sviluppare una fitta comunicazione con le altre figure professionali per evitare pericolosi accentramenti.
L’esperienza operativa maturata nelle precedenti annualità, ci ha consentito in progress di effettuare scelte organizzative e metodologiche rispondenti ai bisogni emersi. La qualità dell’accompagnamento è garantita dalla scelta di individuare un operatore di riferimento che funga da interfaccia tra la comunità e gli altri attori coinvolti nel processo di presa in carico.
Per quanto riguarda le attività di routine, il percorso educativo del minore, nell’ottica delle pari opportunità, contempla le seguenti attività: > Accudimento, cura e pulizia per l’igiene personale; > Cura dell’alimentazione > Accompagnamento di tutela della salute; > Accompagnamento nel gioco; > Sostegno all’inserimento scolastico e alla socializzazione; > Accompagnamento alla psicodiagnosi, e altri interventi di accompagnamento del minore che si rendessero necessari (es. TpM, eventuali incidenti probatori ecc.); > Accompagnamento nella fruizione guidata di programmi televisivi e di ogni altro media; > Accompagnamento nella partecipazione ad iniziative spettacolari, culturali, sportive e di tempo libero rivolte all’infanzia; > Accompagnamento nelle vacanze durante il periodo estivo.
Le attività qui sinteticamente elencate non sono mai intese come prestazioni. Lo stile relazionale ne caratterizza la capacità d’impatto e la valenza educativa. In particolare va sottolineato che, in presenza di genitori protettivi, qualsiasi attività ne prevede il coinvolgimento, al fine di attivarne le risorse residue. Tale scelta metodologica discende dall’opportunità di agevolare la ricostruzione di un modello familiare più ecologico. Ai i genitori protettivi vengono forniti strumenti ed occasioni di analisi e confronto riguardo alle scelte educative operate. Si tratta di un precorso insidioso la cui unica possibilità di riuscita è garantita dallo stabilirsi di un’alleanza educativa. Si mira al raggiungimento del risultato, attraverso l’attenzione critica alla dinamica che intercorre tra madri e figli, attraverso una formazione indiretta ( spesso le madri riconoscono la diversa presa sui bambini degli interventi degli educatori ), l’accompagnamento ad un’assunzione serena delle loro responsabilità. Per ottenere questo risultato l’equipe della Crisalide opera sia nell’individuazione delle capacità delle madri, che delle difficoltà personali da loro espresse. Il lavoro svolto ha l’obiettivo di renderle più competenti nell’esercizio delle funzioni genitoriali. Questa particolare azione prevede anche misure specifiche di accompagnamento ( es. percorsi terapeutici) a cui, pur salvaguardando i suoi compiti prioritari, la Comunità si rende disponibile a collaborare. Per quanto riguarda i minori, per l’ottemperanza ai compiti educativi rispetto alle particolari condizioni presentate dal tipo d’utenza, l’organizzazione della vita comunitaria sarà strutturata in modo da garantire un elevato livello di controllo delle eventuali possibili interazioni problematiche tra i minori, quali comportamenti aggressivi e nello specifico, comportamenti sessualizzati. Metodologicamente tutti gli interventi educativi saranno basati sull’equilibrio tra contenimento e comprensione dei comportamenti problematici e sintomatici.
METODOLOGIELa comunità ha la consapevolezza, di rappresentare un intervento a termine. La comunità è un passaggio non una sistemazione definitiva. I soggetti accolti sono sostanzialmente aiutati a progettare e realizzare il proprio futuro oltre la comunità. Senza queste premesse, la comunità rischierebbe di svolgere un compito assistenziale di carattere residuale, secondo i vecchi modelli di welfare. L'equilibrio da trovare è tra un tempo di permanenza che sia il più breve possibile, comunque adeguato ai bisogni ed ai problemi del minore accolto, e un tempo vissuto intensamente ed utilmente per favorire l'acquisizione e/o il recupero d’identità personale, sicurezza interiore, capacità relazionali, competenze. Tuttavia nelle situazioni di maltrattamento ed abuso, parallelamente alle quotidiane essenziali funzioni educative necessarie alla crescita dei bambini, la comunità attiva nei confronti delle persone accolte azioni a specifica valenza protettiva e terapeutica. Le scelte a riguardo sono all’attenzione costante dell’equipe, nella consapevolezza che qualunque scelta operata ha per questi bambini una specifica valenza terapeutica. I bambini sono seguiti da operatori con modalità relazionali caratterizzate da attenzione costante agli specifici bisogni individuali. L’emersione di tali bisogni è monitorata e valutata in seno alle riunioni d’equipe. In tale compito saranno supportati come gruppo da un supervisore esterno. Lo psicologo supervisore assicurerà per quanto di sua competenza, l’adeguatezza in termini psicologici delle risposte educative ipotizzate. Questi, inoltre, ma anche individualmente ove mai ce ne fosse bisogno, si occuperà di contenere il rischio di bourn out negli operatori, anche con colloqui individuali ove opportuno.
Per ogni minore accolto è impostato un programma pedagogico di recupero specifico individualizzato che miri a: > fornire attenzione alla sua individualità e ai suoi bisogni psico-affettivi. > sostenere il minore nell’istruzione e nell’inserimento sociale. > offrirgli uno spazio strutturalmente idoneo ed adeguato all’accudimento della sua persona, nonché ad una maturazione affettiva equilibrata. > garantirgli, attraverso il collegamento con i servizi sociosanitari del territorio, il suo benessere psicofisico. >sostenerlo opportunamente nei suoi rapporti con la famiglia laddove questi siano possibili ed utili alla sua evoluzione, e a tutelarlo, anche in ottemperanza a disposti della magistratura, laddove tali rapporti siano disturbanti. > verso il genitore accolto sarà svolta un’opportuna opera di sostegno e d’aiuto, considerata la prevedibile situazione di difficoltà materiale ed affettiva in cui si verrà a trovare. Ove mai ce ne fosse bisogno, sarà aiutato ad assumere in modo sempre più adeguato il ruolo genitoriale. > partecipare e sollecitare le equipe interistituzionali in modo da verificare e riformulare periodicamente il progetto individuale dell’ospite. > considerare l’ospite una risorsa per il progetto.
Metodologia adottata nella relazione con i minori. La metodologia di lavoro adottata procede su un modello di osservazione sistematica. L’osservazione è alla base di ogni intervento svolto dalla comunità ed è funzionale alla redazione del progetto educativo personalizzato. In definitiva grazie all’osservazione si rilevano e si verificano i reali bisogni dei bambini, che spesso sono bisogni speciali a cui bisogna dare risposte speciali. I bambini ospitati, infatti, spesso pervengono alla comunità per motivi che esplicitano solo parzialmente i bisogni reali. In questo senso l’osservazione costituisce il cardine su cui s’impernia la significatività e la capacità d’impatto dell’intervento. Concettualmente tutti i bambini che sono inviati in comunità presentano situazioni di disagio. Solo l’osservazione dei singoli bambini può produrre informazioni idonee ad approfondirne la conoscenza specifica, individualizzata su come ciascun bambino personalmente interpreta e produce comportamenti sintomatici. Mediante l’analisi di queste informazioni mutuate dall’osservazione, è possibile proporre delle alternative ai comportamenti espressione di sintomi, collaborando così a livello educativo, all’elaborazione delle situazioni che hanno causato il disagio. Tale attenzione ci sembra aumentare la possibilità che la permanenza in comunità possa costituire fattore prognostico positivo per il successivo reinserimento del minore in un contesto familiare, sia che si tratti della propria famiglia d’origine, sia che si tratti di una famiglia adottiva. Tuttavia va sottolineato che a dar forma all’attività informativa interviene un’impostazione metodologica fondata sulla partecipazione empatica. L’osservazione è da intendersi anche nell’accezione di osservazione partecipata. Solo questa comprensione empatica fornisce reali informazioni sui bambini. L'empatia è da intendersi come una comprensione dell'altro che si realizza immergendosi nella sua soggettività, senza sconfinare nell’identificazione. Gli operatori della Crisalide sono in grado di esprimere considerazione e accettazione positiva incondizionata verso le persone ospitate, giacché sono formati ad accogliere in un clima di sospensione di giudizio ogni sentimento verbalizzato, anche quelli negativi o comunemente ritenuti anormali. Solo così la comunità può predisporsi ad offrire un'esperienza emozionale correttiva, che trovi riscontro nella vita quotidiana. Il modello relazionale offerto è un modello altro rispetto ai modelli operativi distorti di cui i bambini hanno fatto esperienza. La proposta di reali altri modelli di pensiero e comportamento acquista significato e senso solo se mediata da adulti con cui hanno sperimentato la possibilità di stabilire rapporti fiduciari e solo se quest’esperienza si traduce in modelli di vita praticabili e compatibili con le storie dei singoli bambini.
PROGETTO EDUCATIVO PERSONALIZZATONel progetto educativo personalizzato sono previsti: un'anamnesi personale e familiare finalizzata ad individuare problemi e risorse, difficoltà e potenzialità; gli obiettivi intermedi di crescita, personalizzati e possibili, adeguati al tempo previsto di permanenza; gli strumenti operativi, interni ed esterni alla struttura residenziale, per raggiungere gli obiettivi stabiliti. Il progetto individuale va orientato allo scopo prioritario dell'accoglienza in comunità: la dimissione per una sistemazione stabile e duratura.
COLLABORAZIONE CON I SERVIZIIl rapporto con i servizi competenti sarà organizzato volta per volta secondo la situazione che si presenta, nella consapevolezza che senza collaborazione con gli altri enti che si occupano del minore il nostro lavoro è vano. La Comunità s’impegna a verificare il progetto educativo personalizzato sia con servizi sociali competenti sia con il Tribunale per i Minorenni, sia con tutti gli altri servizi che si occupano dell’ospite. La Comunità s’impegna a partecipare e sollecitare le equipe interistituzionali.
PERSONALE1 responsabile della comunità. + 8 educatori operatori. + 1 psicologo supervisore + 3 Volontari
FORMAZIONE DEGLI OPERATORIL'evoluzione delle problematiche dell'infanzia, le implicazioni sempre più complesse di un intervento integrato su bambine/i, la fatica di un lavoro emotivamente molto coinvolgente sono i tre fondamentali motivi che individuano come elemento integrante e costante della progettazione un'adeguata formazione di base e l'aggiornamento e la riqualificazione permanente per gli operatori della nostra comunità. Gli operatori sono tenuti a partecipare ad almeno un’iniziativa formativa ogni anno. Inoltre sono tenuti a partecipare alla supervisione quindicinale che si tiene in sede, alla riunione d’equipe interna quindicinale. Alle equipe interistituzionali degli ospiti di cui sono referenti.
ASPETTI SPERIMENTALI
1. LA COMUNITA’ COME AMBIENTE TERAPEUTICOLa comunità d'accoglienza si costituisce come risorsa integrata all'interno dell'intervento complessivo di presa in carico del bambino con una sua specifica valenza terapeutica in ordine alla riparazione del trauma subito dal minore. La comunità può esprimere tale valenza solo se si configura come un ambiente capace di fornire al minore la protezione dalle forme d’abuso subite, l’accompagnamento più idoneo nelle varie fasi dell’intervento previsto dal progetto di rete, e il sostegno funzionale al superamento delle condizioni di pregiudizio vissute.
Per quanto in precedenza espresso, la comunità ritiene di dover rappresentare un modello di tipo familiare, integrato con un contesto relazionale autenticamente orientato a fini terapeutici.
Per realizzare tale ambiente terapeutico ci utilizzeranno specifici strumenti; - Supervisione quindicinali con psicoterapeuta infantile specializzata nella cura di bambini vittime di maltrattamento e abuso sessuale. - Istituzione dell’operatore di riferimento (OdR). - Istituzione dell’equipe psicopedagogica interna, formata dal responsabile della comunità dal supervisore e dell’operatore di riferimento.
IL SISTEMA ORGANIZZATIVO: PROCEDURE OPERATIVE
a. Procedure per l’ammissione> Sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità. > Assenza/presenza di fattori ostativi ( es. emergenze contingenti interne alla comunità, non opportunità, etc.). > Acquisizione documentazione dell’inviante o/e riunione informativa con l’inviante. > Riunione di equipe > Studio del caso > Definizione dell’èquipe > Valutazione ex ante
b. Ricerca anamnestica per la costruzione del percorso/obiettivo educativo.L’attività di ricerca anamnestica per la definizione del percorso educativo assorbe il massimo dell’energia nell’arco delle prime tre-quattro settimane d’accoglienza del minore in comunità. I passaggi procedurali necessari all’acquisizione d’informazioni utili sono i seguenti: > Acquisizione e studio della relazione dell’inviante > Compilazione di schede di rilevazione all’ingresso. - Tipo di affidamento ( 403, decreto TpM ) - Condizioni sanitarie - Abbigliamento - Abitudini alimentari - Qualità del sonno - Abilità e autonomia - Linguaggio - Cura di sé - Annotazioni particolari - Informazioni sui familiari - Registrazione della modalità di ricezione ed acquisizione della vita comunitaria in un periodo stabilito. > Compilazione di schede d’osservazione all’ingresso. > Compilazione del diario degli operatori: “Alla scoperta di…”
c. Definizione del percorso/obiettivoUna volta acquisite le informazioni, attraverso l’applicazione degli strumenti, secondo la tempistica precedentemente esposta, si riterrà di essere entrati in possesso di un minimo d’informazioni utili a redigere un progetto educativo. A tal fine si procederà nel seguente modo: > Riunione del gruppo di lavoro della comunità. - Analisi dei dati registrati - Discussione sui dati raccolti - Assessment dei bisogni espressi e inespressi. - Redazione del percorso/obiettivo - Definizione calendario riunioni del gruppo di lavoro interno per aggiornamento e verifica del percorso/obiettivo. - Definizione calendario equipe interistituzionale. - Calendario stesura report periodici ( dossier del percorso ). - Eventuale implementazione ( o richiesta d’implementazione ) dell’èquipe. - Stesura del verbale della riunione
d. Comunicazione referenti istituzionali> Invio progetto educativo al S.S. ( ogni tre mesi ) > Invio Schede Minori Procura della Repubblica presso il TpM (ogni 6 mesi). > Invio relazione al Tribunale per i minorenni > Comunicazione dell’ipotesi di calendario delle riunioni dell’equipe interistituzionale.
e. Procedure in itinereIl processo che si è innescato con la presa in carico del minore, necessita di momenti di verifica in itinere. Tali momenti sono funzionali all’individuazione d’eventuali nodi critici, all’acquisizione di nuove informazioni. Inoltre, a cadenza periodica, ( ogni due mesi ), a decorrere dalla stesura del primo progetto educativo personalizzato di ciascun bambino ospitato, saranno utilizzati gli strumenti adottati dalla comunità per la rilevazione dei dati utili a monitorare la pertinenza del lavoro educativo ed eventualmente, attraverso il contributo dell’equipe della comunità all’interno dell’equipe interistituzionale integrata, dell’intero processo di presa in carico. > Dossier del percorso ( rilevazioni periodiche mediante le schede prima citate). > Eventuali riunioni straordinarie > Emergenze critiche > Registrazione incontri con i familiari > Osservazioni sui rientri in famiglia > Report periodici
IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀPer compiere un’azione di monitoraggio è necessario dotarsi di un sistema di rilevazione strutturata di dati pertinenti a descrivere quantitativamente e qualitativamente il servizio offerto. I dati sono rilevati mediante strumenti opportunamente individuati. Gli strumenti, infatti, devono possedere la capacità di rilevare le caratteristiche specifiche del servizio. La costruzione di un sistema di monitoraggio consente il raggiungimento di diversi obiettivi per l’ottimizzazione del servizio. In primo luogo costituisce un elemento chiaro, inequivocabile e leggibile di sostegno all’attività decisionale. Un’azione sistematica e corretta di monitoraggio, rileva informazioni adeguate a produrre indicazioni utili in merito alle azioni intraprese per determinare il miglioramento delle condizioni di vita dei beneficiari ( nel nostro caso dei bambini ospitati dalla comunità ). I dati saranno rilevati in modo da essere utili a chiarire la pertinenza delle azioni intraprese, sia in termini d’efficacia sia in termini d’efficienza. Essi quindi, giacché opportunamente individuati, consentiranno di ridurre la complessità dei processi decisionali. Le azioni proposte consentiranno di comprendere in itinere l’impatto del processo di presa in carico per quanto attiene alla Comunità la Crisalide.
Il sistema di monitoraggio quindi può garantire un significativo supporto ai processi decisionali riguardanti gli aspetti di seguito elencati: > operazioni di modifica e/o rimodulazione ( ai progetti educativi, alle modalità di svolgimento degli interventi, alle modalità di relazione con gli altri soggetti coinvolti nel processo di presa in carico ); > apprendimento individuale; > rimodulazioni dell’impianto organizzativo, nei termini di “learning organization”, con l'unico preciso obiettivo del miglioramento del servizio all’utente, alla comunità e ai cittadini.
L’adozione d’azioni sistematiche di rilevazione di dati congrui e pertinenti ad evidenziare le condizioni in essere dei bambini ospitati, rende possibile, in ogni momento, agli operatori della comunità di fare il punto della situazione, in modo da scegliere il percorso che si addice meglio al bambino nella circostanza contingente. E’ questo un modo per ricercare l’efficacia ottimale del gruppo di lavoro. Ciò inoltre costituisce premessa indispensabile ad avere nei confronti del bambino un approccio professionale. In tal senso le attività di monitoraggio possono definirsi come una sorta di supervisione strutturata e sistematica del sistema organizzativo che opera la presa in carico del minore per quanto di pertinenza della comunità. Attraverso l’azione di monitoraggio si può quindi ottenere la massimizzazione delle risorse messe in atto dal servizio stesso.
Le informazioni raccolte sono: - di tipo descrittivo ( cosa si fa, a chi è rivolto l’intervento, chi effettua l’intervento, ecc. ). - di tipo processuale ( quali processi sono messi in atto ).
Il sistema di monitoraggio è costruito per rilevare informazioni utili a descrivere l’andamento del servizio nel suo complesso. Pertanto i dati, congruentemente e trasversalmente alle attività, sono rilevati mediante tecniche e strumenti adeguati a declinare: - la condizione in essere dei bambini ospitati; - la condizione degli operatori; - la condizione del servizio nel suo complesso.
La condizione in essere è soggetta a modificazioni. L’azione di monitoraggio è quindi definibile come azione parallela a tutte le altre attività ed interventi erogati. L’azione di monitoraggio è orientata da specifiche batterie d’indicatori. L’indicatore è un elemento che fornisce informazioni, dotato della capacità d’essere operativizzabile. Pertanto l’indicatore si presta ad essere empiricamente osservato. Gli indicatori utilizzati rendono conto di tutte le attività previste dall’esecuzione progettuale ed in particolare tendono a misurare, come già esplicitato, lo stato dell’azione progettuale con riferimento alla condizione dei bambini, degli operatori, del servizio. Gli indicatori che descrivono la condizione degli operatori e dello stato del servizio sono rilevabili mediante alcuni strumenti di gestione (es. foglio firme degli operatori, report mensile di rendicontazione delle ore erogate, cartella degli operatori, ecc.). A titolo esemplificativo elenchiamo alcuni indicatori d’efficacia/efficienza del servizio: - n° d’incontri di verifica e rimodulazione dei P.E.P. - Rapporto istanze ammissione al servizio/utenti in carico. - Rapporto Operatore/prestazioni erogate - Rapporto ore lavoro/pro capite - Documentazione/verbalizzazione dell’attività - Contatti con la rete del volontariato/associazionismo locale aderente e non al progetto. . Allo strumento di rilevazione è intrinsecamente connessa la tempistica e la modalità di registrazione dei dati. Ulteriori indicatori sono desumibili da altri strumenti specifici. In particolare, la condizione di ciascun bambino è monitorata continuamente in relazione agli obiettivi specifici della comunità e del progetto educativo. Strumento principale di raccolta dati è la cartella personale del bambino.
> Cartella personale del bambino La Cartella personale del bambino è un fascicolo organizzato in diverse sezioni. In essa è contenuta l’intera documentazione relativa a ciascun minore preso in carico dalla comunità.
Sezioni della cartella personale del bambino. a Sezione Sanitaria Contiene tutte le informazioni utili a conoscere lo stato di salute del bambino durante tutto il periodo di permanenza all’interno della comunità. La prima pagina contiene un elenco sintetico degli accompagnamenti sanitari effettuati.
b Sezione Educativa Nella sezione educativa sono contenuti i PEI, i reports delle rilevazioni sistematiche sulle aree d’interesse educativo effettate dall’equipe della comunità, le schede d’osservazione utilizzate.
c Sezione Comunicazioni Referenti Istituzionali All’interno di questa sezione sono contenuti i documenti inviati dai S.S., il TPM, le scuole nonché le relazioni inviate dalla comunità ai referenti istituzionali. La prima pagina è costituita da un elenco delle comunicazioni secondo un criterio grafico che renda immediatamente visualizzabile la direzione dei flussi d’informazione in entrata (enti istituzionali verso comunità) e in uscita (Comunità verso enti istituzionali).
L’adozione di un sistema di monitoraggio costituisce il presupposto necessario per operare inoltre un’eventuale successiva verifica degli esiti. Per aumentare il valore euristico del sistema di monitoraggio e valutazione, la Comunità la Crisalide ha allo studio l’implementazione di nuovi strumenti di rilevazione dati. |
|
progetto sperimentare realizzato anche
grazie alla collaborazione della fondazione
|




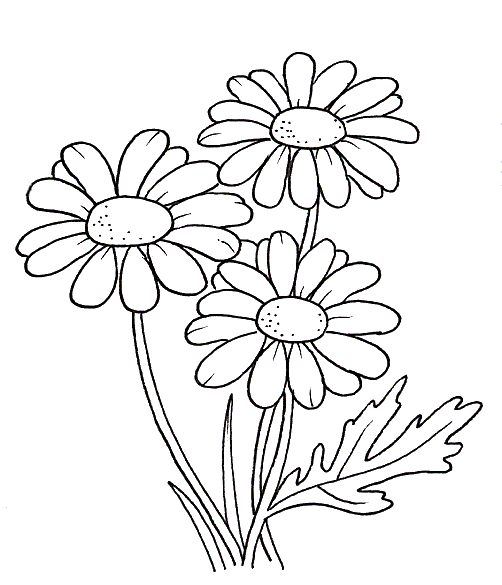 Ci sembra questa una doverosa precisazione. La
Comunità spesso, infatti, deve offrire esperienze relazionali
correttive. Per fare ciò non è sufficiente adottare modelli familiari
tradizionali. Non basta, infatti, togliere alle relazioni l’aspetto
perché queste si configurino come esperienze sane e costruttive per il
bambino che ha sperimentato una situazione d’abuso. La grande attenzione
dovuta alla costruzione di ambienti di vita in grado di sostenere i
difficili compiti di cura di tali bambini ha solo in parte a che fare
con i modelli familiari tradizionali. L’attuazione d’interventi
riparativi e terapeutici, intesi come modalità in grado di riattivare
processi di cambiamento personale, presuppone una lettura professionale
dei compiti di gestione del ménage quotidiano, siano essi riguardanti
l’assolvimento delle mansioni domestiche, piuttosto che gli
accompagnamenti a scuola e quanto altro occorra al funzionamento
quotidiano. L’obiettivo prioritario della comunità, pertanto, è quello
di proporsi come ambiente terapeutico e di cambiamento (Rutter, 1988;
Emiliani, Bastianoni, 1993) attraverso una continua e costante
interpretazione meditata di qualsiasi attività svolta, di qualsiasi
intervento offerto, di qualsiasi momento vissuto, strutturato e non,
routinario o eccezionale che sia. Lo spazio quotidiano caratterizzato da
routine condivise e da un caldo clima relazionale, è un luogo "pensato"
nella sua globalità per realizzare l'intervento riparativo e
terapeutico. La comunità intesa come ambiente terapeutico, si presenta
in continuo rispetto agli altri contesti terapeutici e riparativi. La
validità dell’intervento e la sua capacità d’impatto sono direttamente
proporzionali al livello d’integrazione raggiunto e raggiungibile. Le
attività e le relazioni di ogni giorno offrono informazioni continue
sull’evoluzione dei bambini. Il confronto fra tutti gli operatori
consente all'intero staff di lavorare con un livello di conoscenze e
informazioni più integrato e rende possibile la promozione di situazioni
ambientali atte a produrre rilevanti processi di cambiamento. Un
ambiente comunitario così pensato consente ai ragazzi di poter
rielaborare positivamente le figure parentali per riguadagnarle nel
proprio scenario interno. Il contributo professionale offerto dalla
comunità, così concepita, aumenta notevolmente l’efficacia dell’intero
processo di presa in carico, in particolare per quanto attiene la
relazione che i bambini intratterranno con le famiglie a cui sono
destinati. Agevolando il ripristino di una sana dinamica tra figure
genitoriali interne e loro rappresentazioni esterne, si aumenta la
possibilità di sviluppi positivi degli inserimenti familiari.
Ci sembra questa una doverosa precisazione. La
Comunità spesso, infatti, deve offrire esperienze relazionali
correttive. Per fare ciò non è sufficiente adottare modelli familiari
tradizionali. Non basta, infatti, togliere alle relazioni l’aspetto
perché queste si configurino come esperienze sane e costruttive per il
bambino che ha sperimentato una situazione d’abuso. La grande attenzione
dovuta alla costruzione di ambienti di vita in grado di sostenere i
difficili compiti di cura di tali bambini ha solo in parte a che fare
con i modelli familiari tradizionali. L’attuazione d’interventi
riparativi e terapeutici, intesi come modalità in grado di riattivare
processi di cambiamento personale, presuppone una lettura professionale
dei compiti di gestione del ménage quotidiano, siano essi riguardanti
l’assolvimento delle mansioni domestiche, piuttosto che gli
accompagnamenti a scuola e quanto altro occorra al funzionamento
quotidiano. L’obiettivo prioritario della comunità, pertanto, è quello
di proporsi come ambiente terapeutico e di cambiamento (Rutter, 1988;
Emiliani, Bastianoni, 1993) attraverso una continua e costante
interpretazione meditata di qualsiasi attività svolta, di qualsiasi
intervento offerto, di qualsiasi momento vissuto, strutturato e non,
routinario o eccezionale che sia. Lo spazio quotidiano caratterizzato da
routine condivise e da un caldo clima relazionale, è un luogo "pensato"
nella sua globalità per realizzare l'intervento riparativo e
terapeutico. La comunità intesa come ambiente terapeutico, si presenta
in continuo rispetto agli altri contesti terapeutici e riparativi. La
validità dell’intervento e la sua capacità d’impatto sono direttamente
proporzionali al livello d’integrazione raggiunto e raggiungibile. Le
attività e le relazioni di ogni giorno offrono informazioni continue
sull’evoluzione dei bambini. Il confronto fra tutti gli operatori
consente all'intero staff di lavorare con un livello di conoscenze e
informazioni più integrato e rende possibile la promozione di situazioni
ambientali atte a produrre rilevanti processi di cambiamento. Un
ambiente comunitario così pensato consente ai ragazzi di poter
rielaborare positivamente le figure parentali per riguadagnarle nel
proprio scenario interno. Il contributo professionale offerto dalla
comunità, così concepita, aumenta notevolmente l’efficacia dell’intero
processo di presa in carico, in particolare per quanto attiene la
relazione che i bambini intratterranno con le famiglie a cui sono
destinati. Agevolando il ripristino di una sana dinamica tra figure
genitoriali interne e loro rappresentazioni esterne, si aumenta la
possibilità di sviluppi positivi degli inserimenti familiari.